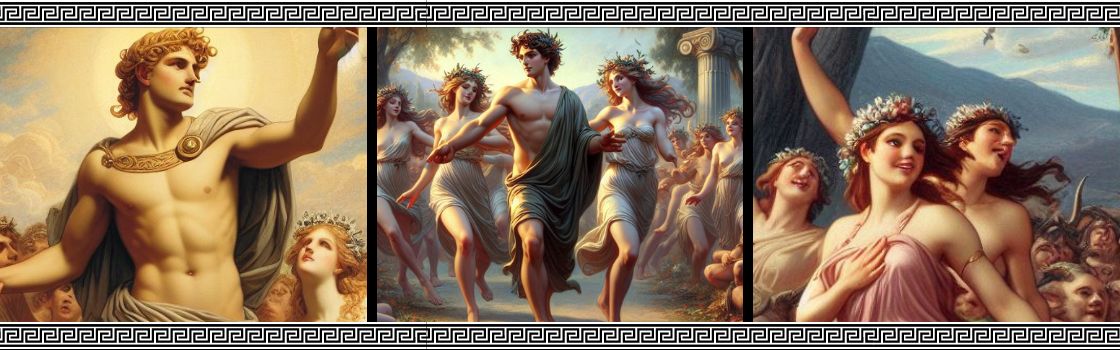Il culto della "Magna Mater" intesa come la Grande Madre degli Dèi fu introdotto a Roma nel corso del II secolo a.C. É riconducibile a Cibele, un'antica divinità anatolica, venerata come Grande Madre Idea, dal monte Ida nei pressi dell'antica città di Ilio.
Dea della forza creatrice e distruttrice della Natura, degli animali e dei luoghi selvatici, Cibele è l'essenza stessa di quella forma di culto primordiale, incentrato sulla figura di una Dea Madre generatrice del tutto, che si sviluppò fin dal Neolitico in varie culture del Mediterraneo e non solo.
Il maggiore centro di culto di Cibele era presso Pessinunte in Frigia. Nel corso del VII sec. a.C. il culto di Cibele si diffuse nelle colonie greche dell'Asia Minore. Infine giunse nel continente; Cibele fu assimilata nel pantheon ellenico a Rea, una titanide, (ovvero una dea antica, nata prima degli Olimpi), generata da Urano (il Cielo), e Gea (la Terra).
Sorella e moglie di Crono, Rea/Cibele è madre di Zeus, Poseidone, Hera, Ade, Demetra ed Estia. Nel 204 a.C., mentre imperversava la Seconda Guerra Punica, i sacerdoti romani trassero dai Libri Sibillini il responso di trasferire nell'Urbe la pietra nera di forma conica, simbolo di Cibele, custodita a Pessinunte.
In tal modo, Annibale sarebbe stato sconfitto. Nel 191 a.C. fu edificato un tempio sul Palatino al fine di custodire l'oggetto, considerato necessario per l'esistenza stessa di Roma. Cibele, come Rea nel mondo greco, è rappresentata seduta su un trono o sul carro trainato da due leoni.
Ovidio racconta che i giovani Atalanta ed Ippomene (o Melanione), freschi sposi, pervasi dal desiderio, profanarono il tempio di Cibele. La Dea, adirata, li trasformò in leoni condannandoli a trainare il suo carro per l'eternità. Dietro il triste epilogo della storia d'amore dei due, c'era la volontà vendicatrice di Afrodite. La Dea greca della bellezza aveva infatti favorito Ippomene nella gara di corsa contro Atalanta. Peccato che Ippomene dimenticò di onorare chi l'aveva aiutato, una volta ottenuta la vittoria e il cuore di Atalanta.
Cibele è sempre accompagnata dal fedele Attis, suo servitore eunuco. Il mito di Attis si lega alla figura di Agdistis, un demone dalla doppia natura maschile e femminile, nato dal tentativo maldestro di Zeus di accoppiarsi proprio con Cibele. La Dea si divincolò sottraendosi alla violenza dell'eccitato Zeus proprio nel momento della sua eiaculazione.
Il seme di Zeus cadde sulla Terra generando il demone intersessuale Agdistis. Questo si invaghì poi del giovane e bellissimo mortale Attis. Ma quando il ragazzo lo rifiutò con convinzione, il demone lo fece impazzire. Attis in preda alla follia si evirò sotto un pino nel giorno stesso del matrimonio con la figlia del re Mida a Pessinunte. Poi si gettò da una rupe, trovando la morte.
Dal suo sangue, cosparso in terra, nacquero le viole mammole. Cibele, impietosita per la sorte avversa del ragazzo, lo rese immortale prendendolo a suo servizio. Esiste anche un altro mito che riguarda la sorte di Attis. Il giovane divenne il desiderio sessuale della stessa Cibele. La Dea, gelosa della ninfa Sangaride, della quale Attis era innamorato, la uccise.
Attis, disperato per la perdita, si tagliò il pene pur di non soddisfare la brama di Cibele. Tuttavia la divinità si pentì della sua stessa crudeltà e salvò Attis da morte sicura, rendendolo immortale e prendendolo al suo servizio.
I romani dedicarono ad Attis un ciclo di festività dal 15 al 28 di Marzo. Tra queste vi era il "Dies Sanguinis" (24 Marzo), cerimonia nella quale i sacerdoti del culto si flagellavano per rappresentare la dipartita del giovane. Il giorno seguente si celebravano le "Hilaria" per festeggiare la sua resurrezione.
Per le strade vi erano cortei giocosi e una processione della statua di Cibele. Nel culto romano abbiamo diverse figure divine che possono essere associate a Cibele, considerate manifestazioni o emanazioni della stessa dea. Da Opi, divinità arcaica di origine sabina, personificazione della terra, alla dea agreste Cerere, passando per la Bona Dea, Tellus e Abbondanza.
Tutte rientrano nel concetto di "Magna Mater Deorum", legate al ciclo riproduttivo della Natura, alla genesi stessa dell'Universo. Tornando ad Attis, il suo ruolo si accentuò in epoca imperiale, evidenziando il dualismo di morte e resurrezione e simboleggiando, per questo, il ciclo vegetativo della primavera. Il culto assunse una connotazione fortemente misterica e soteriologia.
A cura di Andrea Contorni
Note e bibliografia:
- "I Miti Greci" di Robert Graves. Longanesi Editore (2018).
- "La religione romana arcaica" di Georges Dumézil. BUR (2017).